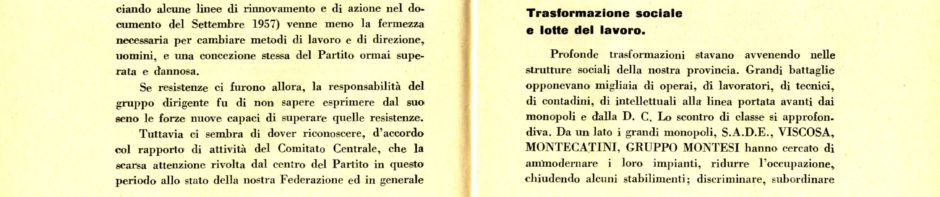Vittorio Pampagnin
Osteria da Angi
Taccuino di memorie dalla Riviera del Brenta
prefazione di Giorgio Roverato
Sommacampagna-Padova, 2006
coedizione con Cierre edizioni
Prefazione
Quando ho iniziato a leggere le storie in questo libro narrate, anche se allora ancor prive di un ordine cronologicamente coerente, ho avuto come la sensazione di trovarmi di fronte ad una sorta di filò fatto di parole scritte, tanto vividi mi apparivano i personaggi e i fatti descritti. Il collante delle vicende che vi compaiono o, meglio, che vi vengono rievocate, è una impalpabile nostalgia per un mondo andato, un mondo a misura d’uomo pur nelle ristrettezze e nella miseria che lo avevano accompagnato.
Conviene ricordare a chi non ha mai partecipato a un filò come esso, a lungo, sia stato nelle campagne venete una vera e propria “istituzione” contadina, momento di socializzazione familiare e comunitaria, occasione di svago e di condivisione di valori, luogo di scambio di opinioni e di informazioni spicciole. E, appunto, di storie… Storie di paese, protagonisti gli amici, i conoscenti, le tante persone spesso identificate con il loro soprannome.
Quel mondo riprende corpo in queste pagine, e rimane come punto di riferimento anche quando l’autore ci riporta a tempi a noi più vicini. L’ambiente è quello della Riviera del Brenta, ma molte delle vicende hanno a che fare con Fiesso d’Artico, il paese dove egli è nato e dove vive.
Questo non è un libro di memorie, bensì, come dicevo, di storie, di sensazioni, di ricordi. E, se vogliamo, non è neanche un libro; è piuttosto un brogliaccio, un taccuino, dove l’autore vuole solo fissare alcuni momenti della sua vita, o di quella degli amici e dei compagni che con lui hanno condiviso i momenti della speranza e della lotta per una società più giusta. In un mosaico di descrizioni che rende la frammentarietà della memoria, ma anche la sua intensità.
Un libro rapsodico, quindi, che tuttavia ha una sua unitarietà grazie alla giustapposizione a posteriori di testi scritti in momenti diversi, frutto appunto dell’esigenza di fermare sulla carta quel determinato ricordo, quella determinata sensazione. Il primo, Tramonto, risale a una decina di anni fa e narra di quel vecchio contadino che a Pampagnin capitò di sorprendere, in uno dei ripidi pendii delle Cinque Terre, mentre – parlando con un olivo, probabilmente ancor più vecchio di lui – cercava di spiegargli che non avrebbe più potuto accudirlo, concimarlo, trarne i suoi frutti: a me è sembrata la accorata rappresentazione di un mondo che stava cambiando troppo velocemente, e che il vecchio non capiva più, che forse si rifiutava di capire. Ed è dal desiderio di tener memoria di questo dramma interiore che Pampagnin ha messo per iscritto quella che, poi, è stata la prima delle sue storie.
Solo che il mondo che muta, tutto cambiando e travolgendo, è anche quello che lui stesso ha visto nella sua esperienza di vita; da qui, a ritroso, gli è venuta la curiosità di recuperare nella sua memoria le proprie esperienze, quasi a esorcizzare quel senso di impotenza e di sconfitta che egli ha avvertito nel contadino ligure. Nascono da questo scavo interiore le altre storie, gli altri spaccati di vita, raccolti in queste pagine. Una lettura intima del proprio vissuto che è, tuttavia, anche testimonianza corale delle profonde trasformazioni che, a partire dal secondo dopoguerra, e più ancora negli anni Cinquanta e Sessanta, investirono la Riviera, e che l’autore ha condiviso con centinaia di donne e di uomini, compagni di lavoro, di sindacato, di lotte politiche.
C’è dentro anche questo nei racconti che Pampagnin ci propone, anche se egli ne parla sommessamente, come di cose normali, frutto naturale delle circostanze della vita. È del resto lo stesso taglio da lui usato nei suoi due libri precedenti (La strada in salita, 1992, e La Riviera degli Scarpari, 2000), nei quali senza enfasi e rifuggendo dalla retorica narra due distinte epopee: quella delle Resistenza, e quella – più materiale, ma non per questo meno affascinante – della quotidiana fatica dei lavoratori calzaturieri della sua terra.
Pur non essendo uno scrittore di professione, dello scrittore di razza Pampagnin tuttavia presenta la chiarezza espositiva, e – soprattutto – la capacità di guidarci per mano là dove egli vuole condurci: a capire i piccoli eventi, a collocarli in una dimensione di più vasto respiro.
Egli scrive nella sua Presentazione che «è nella “storia minore” che nascono, operano vivono e muoiono la maggior parte degli uomini»; e si intuisce che di questa storia, «una storia trascurabile per il suo tempo, inesistente per i posteri ma pur sempre accaduta», egli si sente (orgogliosamente) partecipe. Ma è davvero una storia minore, quella in queste pagine narrata? No, non lo è; è solo una storia che, come tante, gli storici reputano di non dover scrivere, e che invece va recuperata e trasmessa a chi verrà dopo, come del resto anche Pampagnin non inconsapevolmente fa, magari sottacendo il ruolo che ha avuto in qualcuna delle trasformazioni che cambiarono la fisionomia del territorio brentano.
Ma se si fa storia, bisogna farla per intero. Cosicché Vittorio mi perdonerà se sarò io a integrare la sua narrazione. Egli è stato infatti uno dei tanti, tantissimi ancorché ignoti, protagonisti di una storia “altra” di quel Veneto che conobbe, tra il dopoguerra e la fine del secolo scorso, una delle più accelerate crescite dell’Europa continentale; una storia “altra” che stride con le rappresentazioni giornalistiche del capitalismo rampante del Nord Est, e del rapido arricchimento della sua imprenditoria. Le quali quasi mai hanno saputo rapportare quell’indubbio successo alle fatiche individuali e collettive (fatte di uomini in carne ed ossa, di sacrificio, di ritmi di lavoro oppressivi e di bassi salari) che furono alla base di quel modello di sviluppo. Quella che traspare dalle pagine di Pampagnin è la vicenda di un uomo qualunque; il cui lavoro, tuttavia, unito a quello di centinaia di migliaia di donne e di uomini, contribuì a che il “miracolo” economico di questa regione potesse concretarsi. Come dire che se il Veneto divenne – pur ormai non essendolo più – una delle grandi aree europee di sviluppo, ciò fu in gran parte merito della sua classe operaia, e non del solo ceto imprenditoriale. Senza il (determinante) contributo di essa, il Veneto quale noi conosciamo non esisterebbe.
È una storia di miseria, e di fatica, quella che Pampagnin descrive, ma anche di autentica ricchezza umana, intrisa di rapporti familiari, interpersonali, di borgata, di paese, che ormai appartengono al passato, annullati da una modernizzazione superficiale quanto devastante.
Queste pagine hanno il pregio di renderci il mondo dei primi anni Cinquanta, degli anni Sessanta e della decade successiva nella Riviera del Brenta: anni nei quali quell’area, una delle più povere del Nord, andò trasformandosi in un territorio investito da una rapida crescita via via fino al manifestarsi, con la crescita dei redditi individuali, una condivisa agiatezza, pur all’interno delle inevitabili disuguaglianze di una società complessa.
È un’infanzia breve la sua, tipica di un mondo rurale emarginato dallo sviluppo manifatturiero. Adolescente, si ritrova in casa, con il fratello, attorno al desco del ciabattino, imparando da garzone il mestiere che si sta diffondendo in zona: quello dello scarparo. E lo apprende bene questo mestiere, tanto che nel 1958 è assunto alla San Marco, all’epoca uno dei calzaturifici brentani più grandi. È, lì, in fabbrica che inizia la sua formazione; non tanto quella lavorativa, ormai il fare scarpe non ha per lui nessun segreto, quanto quella umana. Vive sulla sua pelle i ritmi del lavoro serializzato, lo sfruttamento che la necessità dell’imprenditore di competere sui mercati stranieri rende quasi naturale, scopre il sindacato, si batte all’interno della CGIL, diventa delegato, si avvicina al Partito comunista. Delegato lo diventa per la sua capacità di relazionarsi agli altri lavoratori, ma anche perché questi apprezzano in lui non solo il fatto di essere un bravo organizzatore ma anche una persona competente nel suo lavoro. Sarà la sua grande opportunità, ma anche la sua sfortuna; opportunità perché comincia a leggere, a studiare, a documentarsi, a scoprire un mondo nuovo; sfortuna perché, dopo una dura lotta sui ritmi del lavoro, l’azienda gli pone un out-out, vale a dire una promozione (anche il padrone riconosceva le sue capacità professionali) in cambio alla rinuncia a fare sindacato. Un rifiuto significa il licenziamento.
Bisogna calarsi nel clima di quegli anni (siamo nel 1964) per capire la drammaticità della scelta. Ma per Pampagnin la dignità personale non ha prezzo, e di fronte al ricatto padronale, sceglie il licenziamento.
Non si sente né una vittima né un eroe. Ha solo scelto di non tradire le sue idee, nulla di più, nulla di meno; e anche questo rientra per lui nella normalità delle cose. Va a fare il metalmeccanico a Marghera, ma il lavoro impersonale nella grande fabbrica non lo soddisfa; gli mancano la concretezza e la responsabilità del proprio impegno lavorativo, cosicché ad un certo punto se ne va e trova un impiego in un impianto per la ricostruzione dei pneumatici vicino a casa. È un lavoro duro, ma implica quell’attenzione e quella responsabilità che l’impersonalità della fabbrica di Marghera gli negava. Si impegna, viene apprezzato, ritrovandosi presto ad essere responsabile del piccolo impianto.
E, tuttavia, il lavoro non gli impedisce di impegnarsi nell’attività di partito: piccole cose, la vita di sezione, le feste de “l’Unità”, la diffusione della stampa comunista. Finché nel 1970 gli viene chiesta la disponibilità a candidarsi per le elezioni amministrative al Comune di Fiesso. Egli accetta, per disciplina di partito più che per interesse ad una esperienza amministrativa. Viene eletto, e la sua vita trascorre – ancora – nella normalità. Fin che, nel 1972, le dimissioni del sindaco fanno sì che la sezione e la Federazione veneziana gli chiedano di subentrare al dimissionario. Pampagnin cerca di negarsi, ma alla fine deve accettare, pensando che la cosa non durerà per molto. Non sarà così. Coprirà il resto della legislatura, e poi verrà riconfermato per le due successive, fino al 1985. Pampagnin vivrà così – da protagonista – le fasi della successiva industrializzazione del suo comune, guidandone armonicamente lo sviluppo in un rapporto molto stretto con imprenditori, associazioni imprenditoriali, sindacati, e soprattutto investendo molto nella politica dei servizi sociali e delle attività culturali.
Mi fermo. Perché questa piccola, ed eterodossa, divagazione in una prefazione? Perché a me non sembra una storia minore: sia per le vicende di una vittima di una rappresaglia antisindacale, sia perché da quella rappresaglia derivò, pur anni dopo, una limpida vicenda amministrativa. Certo, di un piccolo paese, ma tuttavia esemplificativa a livello locale di una più complessiva vicenda provinciale, regionale e nazionale.
Ecco. La storia, la vera storia, è anche questo: saper rapportare il piccolo ad un insieme. Vittorio ce lo fa vedere con i suoi racconti, solo apparentemente strapaesani; io ho voluto integrarne la narrazione dimostrando che la sua “piccola” storia è parte di una più complessiva vicenda di questo paese, nelle quali le discriminazioni antisindacali e i ricatti padronali furono, per molto tempo, la norma. E se essi sono stati sconfitti, o comunque fortemente ridimensionati, ciò è stato, certo assieme a molti altri, merito anche suo.
Piccole storie cresceranno, verrebbe da dire, come la più recente storiografia sta da qualche anno dimostrando.
E grazie, Vittorio, per quanto in queste pagine ci racconti e ci insegni; modestamente, naturalmente, come è nel tuo stile.